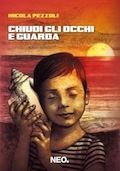Una cosa bisogna dirla subito. I racconti brevi per gli autori (soprattutto quelli esordienti o emergenti) sono un'arma a doppio taglio e lo è anche il modo con cui normalmente vengono pubblicati: le raccolte. Da un lato il racconto è una narrazione complessivamente più semplice da gestire e dalla quale è richiesto all'autore un tempo minore per pervenirne a un'opera compiuta, dall'altro però - proprio per la sua brevità - il racconto ha bisogno di sprigionare tutta la sua forza linguistica e tematica in poche pagine, perché il lettore è questo che chiede a un (bel) racconto breve. Quindi, in pratica, da un lato l'autore di racconti si semplifica la vita, dall'altro però se la complica e non di poco. Ma non è solo questo. Quando un autore emergente pubblica oggi una raccolta di narrativa breve, mediamente ci mette tutti o almeno la gran parte dei racconti che ha scritto. Quello che voglio dire è che, in questi casi, non si tratta quasi mai di "antologie", ovvero di raccolte di testi scelti tra una messe molto più vasta, magari anche in base a un filtro basato sull'apprezzamento ricevuto dal pubblico nel corso di anni grazie ai riscontri su altre pubblicazioni, anche perché purtroppo questa modalità in Italia non è (più) possibile, perché di fatto in Italia il singolo racconto non ha vetrine e non ha mercato, non sapendo bene se la prima mancanza è causa della seconda, o viceversa. Dunque gli autori, sia quelli emergenti, che quelli già affermati, che vogliono cimentarsi con la narrativa breve, devono compilare delle raccolte i cui contenuti non sono già passati al vaglio del pubblico, dunque con il rischio di avere, nell’ambito dello stesso volume, una certa disomogeneità di testi. Considerazione questa, che è amplificata enormemente dalla soggettività del lettore, per cui alla fine è sempre piuttosto difficile trovare una raccolta di narrativa che ci soddisfi in toto. C'è sempre fisiologicamente qualche racconto che si apprezza meno degli altri e questo finisce per depotenziare sempre in qualche misura l'oggetto letterario chiamato "raccolta di racconti", chiunque ne sia l'autore, beninteso. E questo è un ulteriore rischio intrinseco cui l'autore di una raccolta di racconti si espone solo per il tipo di proposta letteraria che fa. A questo punto, prima di andare al sodo, devo aggiungere anche un'altra cosa. Personalmente non amo troppo la narrativa breve. Pochissima narrativa breve mi soddisfa quanto un bel romanzo. Tra gli italiani mi viene da citare Buzzati (inarrivabile) e, in qualche misura, Calvino (il cosmicomico). Per dire, il celebrato e obiettivamente geniale Landolfi non mi fa proprio impazzire. Mentre tra gli stranieri, trovo Carver piuttosto noiosetto, apprezzo a corrente alternata Bukowski e Cheever, mentre adoro quasi tutto Saunders e Chiang e parecchio Wallace (quando non esagera).
Tutto questo per dire cosa? Innanzitutto che pubblicare una raccolta di racconti sembra semplice, e in qualche misura lo è, ma pubblicarne una apprezzabile non lo è affatto. In secondo luogo che io con i racconti sono un rompiballe. Così, quando mi sono accostato a Dindalé (ma cosa diamine è 'sto Dindalé?) di Armando Vertorano sono partito con un certo scetticismo, che non è un pregiudizio, ma è comunque un posizione di attesa guardinga, del tipo: ok, sei tu che devi dimostrarmi qualcosa: vediamo cosa sai fare! Dico subito che l'idea del Dindalé, che Vertorano doverosamente spiega all'inizio del libro, mi è piaciuta moltissimo. Ha dentro qualcosa di molto umano e di familiare, un tocco speciale, sia nell'idea in sé, sia nel modo con cui viene presentata, ovvero quel modo particolare che sua madre usava (o usa ancora?) per rispondergli "chisseneimporta!" a fronte di una sua richiesta di bambino, una maniera molto elegante, ma anche dal suono esotico o magico nel suo essere espressa attraverso una formula inventata (e quindi in questo modo anche affettuosa, perché espressione di un linguaggio segreto di cui solo gli interlocutori sono depositari del significato), per dirgli "ma lascia perdere!". Di certo era un modo molto furbo per chiudere le questioni. Se fosse un gioco di ruolo, come si dovrebbe rispondere a un Dindalé? Sembra l'arma definitiva! Partendo da questo concetto e ampliandolo alla vita di tutti i giorni, a quei muri che la vita adulta ci chiede a volte di scavalcare, a volte di abbattere, dopo magari esserci schiantati, Vertorano confeziona una raccolta di racconti davvero particolare, perché partendo da situazioni minimaliste ci attesta quasi sempre un elemento di più o meno lieve surrealismo con il quale fa deragliare il racconto su binari solo leggermente paralleli alla realtà, ma con il quale catalizza la forza delle sue storie. Per dire, avete mai pensato che se smettessimo di lavarci, potremmo vivere per sempre (Sia maledetta l'acqua)? Oppure che un colpo di tosse possa diventare un'opera d'arte (Il colpo di tosse)? O ancora come potrebbe fare il turista un cieco (Il turista)? O ancora cosa fare se andassi a cercare un navigatore perché ti sei perso, ma trovassi tutt'altro (Dialogo tra un venditore di navigatori e un tizio che si è perso, un racconto equidistante tra Buzzati e Leopardi)? Ma ce ne sono anche altri dove il surrealismo è più delicato, tipo quello del camionista il quale nel corso di una consegna importante, a un certo punto fa una deviazione assurda (che non vi dico quale, ma il titolo del racconto è Venere) o quello in cui lo scrittore chiede al proprio editor cosa fare della propria vita come fosse il finale di un libro (Il finale)? E poi ci sono quelli in cui il surrealismo è quasi assente, sostituito però da una certa dose di ironia. Sono racconti quasi calati nella cronaca quotidiana, come quello del politico costretto a qualcosa di impensabile per riparare a un errore imperdonabile (L'altro lato di dio) o quello che si addentra nei pericolosi territori dei pettegolezzi da ufficio (Gli occhi addosso). Come si può evincere da queste piccole indicazioni, si nota già subito uno dei maggiori pregi della raccolta: quello di spaziare nei temi più disparati. Leggendoli, insomma, non si rischia mai il deja vu e questo è molto importante, perché conferisce sempre nuova freschezza alla lettura. Se poi dovessi attribuire un aggettivo allo stile di Vertorano, direi "delicato". L'autore affronta infatti la narrazione sempre con una sensibilità in punta di piedi, un modo che di tanto in tanto forse lo fa diventare un tantino troppo colloquiale, ma questo sono venialità soggettive. Al di là del fatto che, come dicevo inizialmente, ci sono stati dei racconti che ho apprezzato di più, probabilmente per predilezione personale (quelli, appunto, illuminati dal surrealismo), se devo trovare un appunto complessivo, è l'impressione che Vertorano abbia qua è là tirato indietro la mano sul più bello. Spesso infatti (sempre?) i racconti terminano in un'atmosfera sospesa che, se a volte ho trovato deliziosa e contestuale, altre mi ha lasciato un po' appeso alla voglia di vedere appioppata una bella zampata finale. Ma forse, ripensandoci, è proprio quello che Vertorano si aspetta dal suo lettore. Che anche lui, insomma, alla fine sia portato a far risuonare il suo bel Dindalé sui tetti del mondo!
Dindalé. Conti di poco conto, di Armando Vertorano (Pesci rossi goWare).
Tutto questo per dire cosa? Innanzitutto che pubblicare una raccolta di racconti sembra semplice, e in qualche misura lo è, ma pubblicarne una apprezzabile non lo è affatto. In secondo luogo che io con i racconti sono un rompiballe. Così, quando mi sono accostato a Dindalé (ma cosa diamine è 'sto Dindalé?) di Armando Vertorano sono partito con un certo scetticismo, che non è un pregiudizio, ma è comunque un posizione di attesa guardinga, del tipo: ok, sei tu che devi dimostrarmi qualcosa: vediamo cosa sai fare! Dico subito che l'idea del Dindalé, che Vertorano doverosamente spiega all'inizio del libro, mi è piaciuta moltissimo. Ha dentro qualcosa di molto umano e di familiare, un tocco speciale, sia nell'idea in sé, sia nel modo con cui viene presentata, ovvero quel modo particolare che sua madre usava (o usa ancora?) per rispondergli "chisseneimporta!" a fronte di una sua richiesta di bambino, una maniera molto elegante, ma anche dal suono esotico o magico nel suo essere espressa attraverso una formula inventata (e quindi in questo modo anche affettuosa, perché espressione di un linguaggio segreto di cui solo gli interlocutori sono depositari del significato), per dirgli "ma lascia perdere!". Di certo era un modo molto furbo per chiudere le questioni. Se fosse un gioco di ruolo, come si dovrebbe rispondere a un Dindalé? Sembra l'arma definitiva! Partendo da questo concetto e ampliandolo alla vita di tutti i giorni, a quei muri che la vita adulta ci chiede a volte di scavalcare, a volte di abbattere, dopo magari esserci schiantati, Vertorano confeziona una raccolta di racconti davvero particolare, perché partendo da situazioni minimaliste ci attesta quasi sempre un elemento di più o meno lieve surrealismo con il quale fa deragliare il racconto su binari solo leggermente paralleli alla realtà, ma con il quale catalizza la forza delle sue storie. Per dire, avete mai pensato che se smettessimo di lavarci, potremmo vivere per sempre (Sia maledetta l'acqua)? Oppure che un colpo di tosse possa diventare un'opera d'arte (Il colpo di tosse)? O ancora come potrebbe fare il turista un cieco (Il turista)? O ancora cosa fare se andassi a cercare un navigatore perché ti sei perso, ma trovassi tutt'altro (Dialogo tra un venditore di navigatori e un tizio che si è perso, un racconto equidistante tra Buzzati e Leopardi)? Ma ce ne sono anche altri dove il surrealismo è più delicato, tipo quello del camionista il quale nel corso di una consegna importante, a un certo punto fa una deviazione assurda (che non vi dico quale, ma il titolo del racconto è Venere) o quello in cui lo scrittore chiede al proprio editor cosa fare della propria vita come fosse il finale di un libro (Il finale)? E poi ci sono quelli in cui il surrealismo è quasi assente, sostituito però da una certa dose di ironia. Sono racconti quasi calati nella cronaca quotidiana, come quello del politico costretto a qualcosa di impensabile per riparare a un errore imperdonabile (L'altro lato di dio) o quello che si addentra nei pericolosi territori dei pettegolezzi da ufficio (Gli occhi addosso). Come si può evincere da queste piccole indicazioni, si nota già subito uno dei maggiori pregi della raccolta: quello di spaziare nei temi più disparati. Leggendoli, insomma, non si rischia mai il deja vu e questo è molto importante, perché conferisce sempre nuova freschezza alla lettura. Se poi dovessi attribuire un aggettivo allo stile di Vertorano, direi "delicato". L'autore affronta infatti la narrazione sempre con una sensibilità in punta di piedi, un modo che di tanto in tanto forse lo fa diventare un tantino troppo colloquiale, ma questo sono venialità soggettive. Al di là del fatto che, come dicevo inizialmente, ci sono stati dei racconti che ho apprezzato di più, probabilmente per predilezione personale (quelli, appunto, illuminati dal surrealismo), se devo trovare un appunto complessivo, è l'impressione che Vertorano abbia qua è là tirato indietro la mano sul più bello. Spesso infatti (sempre?) i racconti terminano in un'atmosfera sospesa che, se a volte ho trovato deliziosa e contestuale, altre mi ha lasciato un po' appeso alla voglia di vedere appioppata una bella zampata finale. Ma forse, ripensandoci, è proprio quello che Vertorano si aspetta dal suo lettore. Che anche lui, insomma, alla fine sia portato a far risuonare il suo bel Dindalé sui tetti del mondo!
Dindalé. Conti di poco conto, di Armando Vertorano (Pesci rossi goWare).