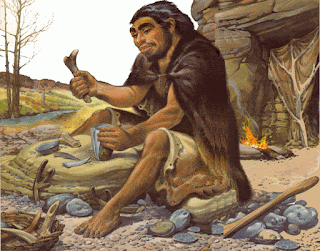È bello avere un'occasione come il Back to the Future Day, per organizzarsi una serata un po' nerd, insomma alla Big Bang Theory, per chi sa di cosa parlo, mangiare sul divano e farsi una maratona di film, di fronte a una birra per chi piace la birra, o di fronte a un chinotto per chi piace il chinotto. Ed è bello rivedere, ogni tanto (ma non troppo spesso), film che in qualche modo hanno segnato la nostra adolescenza. Nel mio sentirmi figlio degli anni '80, non perché sono nato in quel decennio, ma perché in quel decennio sono passato dagli undici ai vent'anni, e nel mio essere da sempre appassionato di cinema, Ritorno al futuro occupa un posto particolare, come lo occupano la trilogia di Indiana Jones (non scherzate, non esiste un Indiana Jones 4), i vari Alien, Terminator e, ovviamente, la prima trilogia di Star Wars. Ed è senza dubbio qualcosa che ormai ha (molto) a che fare con la nostalgia.
Per noi, nati a cavallo tra gli anni '60 e i '70, questi film irripetibili, appassionanti ed emozionanti sono le nostre madeleine proustiane e non si può escludere di inciamparsi per sbaglio in una lacrima quando ci si ritrova (di nuovo) al Ballo Incanto Sotto Il Mare e si sente Marvin Berry intonare Earth Angel. Perché se per puro caso a me capitò di vedere Ritorno al futuro al cinema (giuro) proprio il 26 ottobre 1985, all'epoca tutti noi avevamo più o meno l'età di Marty McFly, quell'età in cui il futuro era ancora tutto lì, davanti a noi. Quello era un momento in cui stavamo imparando a guidarla, la DeLorean, a partire dalle manovre più semplici s'intende, il resto ce lo avrebbe insegnato l'esperienza, la strada, i chilometri sotto le ruote, le gomme bucate, gli incidenti e i traguardi tagliati. Era un momento in cui avevamo la consapevolezza di approssimarci all'incerto confine a partire dal quale si cominciava a fare sul serio, o almeno a intravedere che ci sarebbe stato un momento, da lì a poco, in cui la vita avrebbe lasciato quel volante completamente nelle nostre mani. Ma, grande Giove, all'epoca tutte le strade erano nostre!
Così rivedere Ritorno al futuro a trent'anni di distanza ci fa ritornare a come, nel passato, guardavamo al nostro futuro, con il mistero e la curiosità di scoprirlo, con la passione e forse anche con un po' di paura, ma anche con la voglia pazza di entrarci dentro con tutti i capelli, le scarpe e magari un giubbotto di salvataggio, bruciare le tappe, inzupparci di possibilità, e a come adesso guardiamo invece il nostro passato, alle generazioni che si susseguono, a quello che siamo diventati noi, un giorno alla volta, una piccola decisione dietro l'altra, senza quasi accorgercene, senza salti temporali, senza almanacchi, senza fughe a 88 miglia all'ora, e a quello che abbiamo lasciato per strada, alle occasioni perdute, ai pugni che avremmo dovuto dare e non abbiamo dato, ai fulmini che abbiamo schivato e a quelli che invece ci hanno preso in pieno, alle cose che abbiamo rimandato troppo a lungo, ai volti che non vediamo più e la colpa è solo nostra, ai baci che avremmo dovuto dare e invece non abbiamo dato, alle canzoni che avremmo dovuto suonare e a quelle che abbiamo effettivamente suonato.
Ritorno al futuro non è solo un film perfetto come può esserlo un film, ma come purtroppo sempre più di rado lo sono i film. Un film con una sceneggiatura da manuale, piena di gag (per dire, quella dello zio Joey è fantastica), rimandi, trovate, ritmo e naturalezza, una colonna sonora eccezionale (lunga vita ad Alan Silvestri!) e un casting impeccabile. Ritorno al futuro ci dice anche (o soprattutto) che tutte le possibilità ci sono aperte, ma che dobbiamo fare le scelte giuste fin dall'inizio, che dobbiamo avere coraggio, che dobbiamo mettere da parte il nostro orgoglio, che non possiamo barare e che non tutti i bivi sono uguali. Sta a noi capire quelli che sono veramente cruciali per determinare quello che saremo o, meglio, quello che vorremo essere. Ma la sua bellezza assurda è che lo si può guardare con soddisfazione da tutte le prospettive, ovvero a seconda di come ci posizioniamo sull'ascissa temporale della nostra vita. Solo l'effetto-madaleine cambierà. Il divertimento e la sorpresa lasceranno un po' di spazio alla nostalgia e (forse) a qualche rimpianto, ma quello che resterà fermo, inossidabile, sarà che per quanto futuro ci resterà davanti, quello sarà sempre e comunque il nostro futuro e dovremo essere noi a farci in quattro per fare in modo che sia come noi vogliamo che sia.
Per noi, nati a cavallo tra gli anni '60 e i '70, questi film irripetibili, appassionanti ed emozionanti sono le nostre madeleine proustiane e non si può escludere di inciamparsi per sbaglio in una lacrima quando ci si ritrova (di nuovo) al Ballo Incanto Sotto Il Mare e si sente Marvin Berry intonare Earth Angel. Perché se per puro caso a me capitò di vedere Ritorno al futuro al cinema (giuro) proprio il 26 ottobre 1985, all'epoca tutti noi avevamo più o meno l'età di Marty McFly, quell'età in cui il futuro era ancora tutto lì, davanti a noi. Quello era un momento in cui stavamo imparando a guidarla, la DeLorean, a partire dalle manovre più semplici s'intende, il resto ce lo avrebbe insegnato l'esperienza, la strada, i chilometri sotto le ruote, le gomme bucate, gli incidenti e i traguardi tagliati. Era un momento in cui avevamo la consapevolezza di approssimarci all'incerto confine a partire dal quale si cominciava a fare sul serio, o almeno a intravedere che ci sarebbe stato un momento, da lì a poco, in cui la vita avrebbe lasciato quel volante completamente nelle nostre mani. Ma, grande Giove, all'epoca tutte le strade erano nostre!
Così rivedere Ritorno al futuro a trent'anni di distanza ci fa ritornare a come, nel passato, guardavamo al nostro futuro, con il mistero e la curiosità di scoprirlo, con la passione e forse anche con un po' di paura, ma anche con la voglia pazza di entrarci dentro con tutti i capelli, le scarpe e magari un giubbotto di salvataggio, bruciare le tappe, inzupparci di possibilità, e a come adesso guardiamo invece il nostro passato, alle generazioni che si susseguono, a quello che siamo diventati noi, un giorno alla volta, una piccola decisione dietro l'altra, senza quasi accorgercene, senza salti temporali, senza almanacchi, senza fughe a 88 miglia all'ora, e a quello che abbiamo lasciato per strada, alle occasioni perdute, ai pugni che avremmo dovuto dare e non abbiamo dato, ai fulmini che abbiamo schivato e a quelli che invece ci hanno preso in pieno, alle cose che abbiamo rimandato troppo a lungo, ai volti che non vediamo più e la colpa è solo nostra, ai baci che avremmo dovuto dare e invece non abbiamo dato, alle canzoni che avremmo dovuto suonare e a quelle che abbiamo effettivamente suonato.
Ritorno al futuro non è solo un film perfetto come può esserlo un film, ma come purtroppo sempre più di rado lo sono i film. Un film con una sceneggiatura da manuale, piena di gag (per dire, quella dello zio Joey è fantastica), rimandi, trovate, ritmo e naturalezza, una colonna sonora eccezionale (lunga vita ad Alan Silvestri!) e un casting impeccabile. Ritorno al futuro ci dice anche (o soprattutto) che tutte le possibilità ci sono aperte, ma che dobbiamo fare le scelte giuste fin dall'inizio, che dobbiamo avere coraggio, che dobbiamo mettere da parte il nostro orgoglio, che non possiamo barare e che non tutti i bivi sono uguali. Sta a noi capire quelli che sono veramente cruciali per determinare quello che saremo o, meglio, quello che vorremo essere. Ma la sua bellezza assurda è che lo si può guardare con soddisfazione da tutte le prospettive, ovvero a seconda di come ci posizioniamo sull'ascissa temporale della nostra vita. Solo l'effetto-madaleine cambierà. Il divertimento e la sorpresa lasceranno un po' di spazio alla nostalgia e (forse) a qualche rimpianto, ma quello che resterà fermo, inossidabile, sarà che per quanto futuro ci resterà davanti, quello sarà sempre e comunque il nostro futuro e dovremo essere noi a farci in quattro per fare in modo che sia come noi vogliamo che sia.